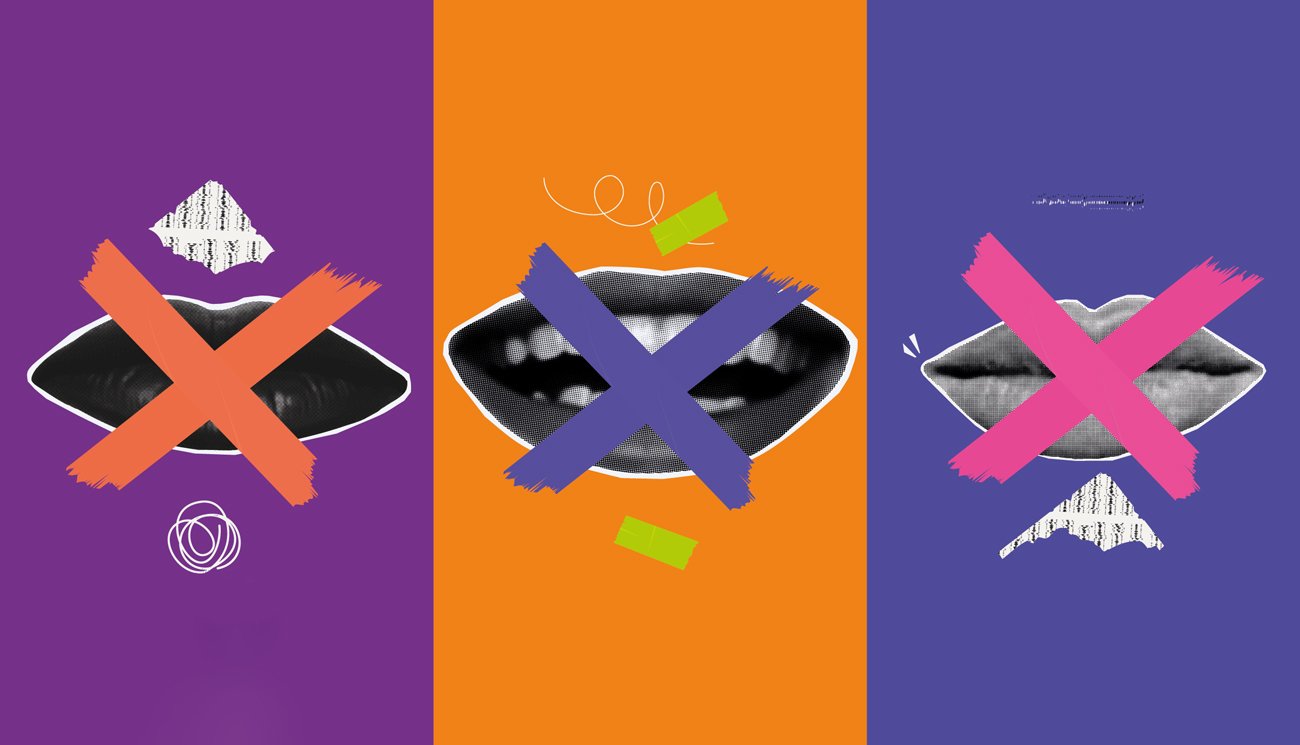

Per una bambina è ancora difficile sognare di fare la scienziata
Studi dimostrano che le donne hanno difficoltà ad accedere alle materie STEM a causa di pregiudizi e stereotipi sociali
Se pensiamo al mondo della scienza potremmo immaginarlo come un enorme caleidoscopio. Avete presente quei giochi a forma di tubo con dentro tante pietrine colorate che si muovono? Ogni pietrina al suo interno rappresenta una scoperta scientifica diversa. Se però noi decidessimo che le scoperte fatte da scienziati uomini fossero di colore nero, mentre le scoperte fatte da scienziate donne di colore bianco, non ci sarebbero molti disegni da guardare. La maggior parte sarebbero infatti completamente neri.
Il divario di genere tra uomini e donne nel mondo scientifico è infatti una caratteristica della realtà accademica e lavorativa attuale. Secondo i dati 2019 dell’UNESCO, meno del 30 per cento dei ricercatori nel mondo sono donne. I dati mostrano inoltre che ci sono differenze per quanto riguarda gli ambiti di ricerca e il tipo di settore lavorativo (pubblico o privato). Ma per comprendere al meglio il cosiddetto gender gap, dobbiamo andare oltre i numeri e identificare i fattori che ostacolano ricerca e carriera delle donne in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM).
L’accesso all’istruzione
All’origine di tutto questo c’è la storica differenza di possibilità di accedere all’istruzione tra uomini e donne. Ad esempio, per quanto riguarda il diritto allo studio in Italia, solo nel 1859 fu compiuta una prima riforma: con la legge Casati sulla pubblica istruzione, infatti, fu resa obbligatoria la frequenza elementare per garantire il diritto all’istruzione a entrambi i sessi. Grazie a questa riforma, fu concesso alle donne anche il diritto di frequentare i licei e accedere all’istruzione superiore, cosa che invece prima non era possibile. Pochi anni dopo, nel 1876, venne compiuto un considerevole passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle donne, in quanto con il regolamento universitario del 27 ottobre 1876 si stabilì che anche le donne potessero «attendere agli studi universitari».
Nonostante l’accesso all’istruzione sia garantito per legge ormai da più di un secolo, almeno per quanto riguarda l’Italia, in ambito accademico-scientifico non si ha ancora oggi una piena parità. Secondo il report “Rethink Ste(a)m education – A sustainable future through scientific, tech and humanistic skills” pubblicato nel 2022 dalla Fondazione Deloitte, la situazione universitaria non sembra giocare a favore delle donne in ambito tecnico-scientifico: le ragazze che in Italia si laureano in un corso STEM sono solo il 14,5 per cento del totale delle laureate. La percentuale dei ragazzi, invece, è pari al 24,5 per cento.
Dal report emerge come le ragioni della carenza di laureate nelle discipline STEM vadano ricercate nell’opinione diffusa secondo cui i corsi tecnico-scientifici non siano adatti alle ragazze: il 50 per cento delle studentesse intervistate parla di stereotipi di genere che le disincentivano dall’intraprendere un percorso di studi in ambito STEM.
Il divario di genere in ambito lavorativo
Secondo uno studio del 2023 finanziato dalla McKinsey & Company il divario accumulato durante il percorso formativo si ripercuote successivamente nel mondo del lavoro, dove la situazione addirittura peggiora. Difatti la presenza femminile nelle imprese tecnologiche dell’UE è inferiore rispetto a quella nelle università e, inoltre, la percentuale di donne negli atenei e nelle aziende è in costante calo. Si tratta di un trend che ha come causa principale la falsa credenza secondo cui le donne non sarebbero predisposte per le materie scientifiche. I ricercatori di McKinsey spiegano come nella scuola primaria e secondaria non c’è nulla che faccia supporre che le ragazze rimangano indietro rispetto ai ragazzi nelle materie scientifiche. Anzi, è vero il contrario: in Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Svezia le ragazze superano leggermente i ragazzi nei test di scienze e matematica, e la stessa cosa succede all’università per quella minoranza di donne che decide di iscriversi alle facoltà STEM.
Un articolo di marzo 2024 pubblicato su Surfshark, azienda di sicurezza informatica, analizza e confronta i dati dei più recenti studi Eurostat sulla presenza femminile nell’ambito STEM e del Gender Equality Index, l’indice di parità di genere. Nel 2022, quasi 1 persona su 6 in Unione europea lavorava nel settore scientifico e tecnologico, per un totale di 76 milioni di persone, tra cui 40 milioni di donne. Leggendo i dati in questo modo la situazione parrebbe positiva, se non fosse che i Paesi con maggior tasso di occupazione femminile in ambito STEM non siano anche i Paesi con un indice di parità di genere più basso. I Paesi con una minore uguaglianza di genere, in generale, hanno visto una maggiore percentuale di donne nei lavori scientifici e tecnologici.
Malta, Italia e Repubblica Ceca sono state notate per avere la più bassa percentuale di donne nella scienza e nella tecnologia, ma le donne rappresentano comunque una percentuale significativa, compresa tra il 46 percento e il 49 percento, della forza lavoro del settore. I punteggi dell’indice di parità di genere a Malta e in Italia sono stati superiori alla media dell’UE (67,6), con punteggi rispettivamente di 67,8 e 68,2.
Le cause tra stereotipi di genere e pregiudizi
Alcuni fattori che contribuiscono notevolmente al divario di genere nelle STEM sono, come abbiamo già accennato, gli stereotipi di genere: molte persone associano ancora i settori STEM a qualità maschili, il che porta le ragazze e le donne a scegliere percorsi ritenuti più “adatti”, come educazione o cura dell’infanzia. Secondo lo studio del 2023 dell’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes, che ha coinvolto oltre 2.000 ragazze italiane dai 14 ai 26 anni, il 50 per cento delle intervistate si sente limitata nella possibilità di scelta per il proprio futuro a causa di stereotipi e retaggi patriarcali.
Un altro fattore che disincentiva le carriere STEM è l’assenza di modelli ai quali aspirare. Non pensiamo a modelli “lontani” da noi, come pioniere della ricerca scientifica, ma soffermiamoci su realtà più semplici, come direttrici, manager e capi ai vertici di aziende. Le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni di leadership, il che rende più difficile trovare mentori nel campo. Secondo i dati del report 2021 dell’Osservatorio dell’Università Cattolica Sacro Cuore (Ocpi) la percentuale di donne che occupano posizioni ai vertici aziendali o di ricerca nell’area tecnico-scientifica è inferiore rispetto ai corrispettivi maschili. Inoltre, il divario si osserva anche a livello salariale. Un altro dato interessante emerge sempre dal report 2021 Ocpi: laureati STEM dichiarano di percepire in media il 21 percento in più rispetto alle laureate donne. Tutto ciò è dovuto a bias cognitivi, ovvero pregiudizi inconsci nelle assunzioni, nelle promozioni e nei finanziamenti che possono svantaggiare le donne e portare a una loro rappresentanza sproporzionatamente bassa nel settore STEM.
Infine, spesso si presenta uno squilibrio tra lavoro e vita privata. Ciò accade in realtà non solo nel mondo tecnico-scientifico, ma in qualsiasi ambito, ed è una dinamica strettamente collegata alla quantità di lavoro non retribuito che pesa sulle donne, ancora oggi viste come figure a cui affidare la cura dei figli e delle persone anziane e lo svolgimento dei lavori domestici. Come ha evidenziato un rapporto del 2020 dell’International Labour Organization (ILO), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti riguardanti il lavoro, in Italia le donne svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito di assistenza e cura al giorno mentre gli uomini un’ora e 48 minuti. Le donne italiane, quindi, si fanno carico del 74 per cento del totale delle ore di lavoro non retribuito di assistenza.
Per questo motivo alcune donne possono così trovarsi costrette a rinunciare alla carriera o a scegliere di lavorare part-time, il che può influire negativamente sull’avanzamento di carriera. Inoltre, spesso accade che durante i colloqui di lavoro alle donne vengano sottoposte domande scomode, come «Hai figli? Vorresti dei figli? Come pensi di bilanciare casa e lavoro?». Si tratta di una modalità di colloquio che in Italia non è ammessa dal codice delle pari opportunità, che all’articolo 27 del decreto legislativo 198/2006 afferma che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro.
In base a uno studio realizzato nel 2020 dal Parlamento europeo sul gender gap nel mondo del lavoro è emerso che una delle cause principali di tale situazione socio-economica è un retaggio culturale di stampo patriarcale, dove ci si aspetta che la donna sia disposta a sacrificare la propria carriera in favore della vita familiare.
Esistono punti di riferimento
Per quanto ci si possa sentire demoralizzate, non bisogna arrendersi. Questo è il pensiero che alcune scienziate e ricercatrici hanno voluto portare come mantra durante la loro carriera. Difatti, nella storia delle scoperte scientifiche, alcune pietrine del nostro famoso caleidoscopio si sono colorate di bianco. Queste pietre bianche appartengono a donne che hanno spiccato per la loro tenacia e determinazione nel farsi strada in un mondo scientifico non sempre accessibile a tutte.
Una delle prime pioniere della ricerca scientifica è stata Marie Curie (1867-1934), chimica e fisica polacca, che ha vinto il Nobel per la fisica nel 1903 e, successivamente, il Nobel per la chimica nel 1911. Curie ha dato un contributo fondamentale allo studio delle radiazioni, oltre ad aver scoperto radio e polonio. Nella storia delle scoperte scientifiche solo 4 persone hanno vinto più di un Nobel, e solo 2 di queste lo hanno fatto in ambiti di ricerca differenti.
Proseguendo troviamo Gerty Cori (1896-1957) biochimica austro-americana, che è stata la prima donna a vincere il Nobel per la medicina (1947). Dopo di lei solo tredici donne sono riuscite a farsi strada e a vincere l’ambito riconoscimento in campo medico. Insieme ad altri due scienziati con cui condivise il premio, Gerty Cori ha scoperto parte del metabolismo dei carboidrati all’interno del corpo umano. Continuò fino alla morte le proprie ricerche, riuscendo addirittura a dare il proprio nome ad un ciclo metabolico, definito appunto Ciclo di Cori.
Infine, Rosalind Franklin (1920-1958) fu una cristallografa e chimica britannica, fu la prima scienziata al mondo a fornire le prove sperimentali della struttura del DNA che valsero il premio Nobel ai colleghi Wilkins, Watson e Crick. Le prime fotografie della celebre doppia elica furono scattate proprio da Franklin, ma le vennero sottratte e per questo non ricevette mai i riconoscimenti meritati. Un classico esempio di come fosse difficile emergere in una società scientifica patriarcale e gerarchica.
Nonostante esistano punti di riferimento di scienziate ormai note, è necessario investire risorse per rendere pienamente effettiva la parità di genere nelle STEM e in qualsiasi altro ambito della nostra società, e permettere finalmente a quelle pietrine bianche di brillare.
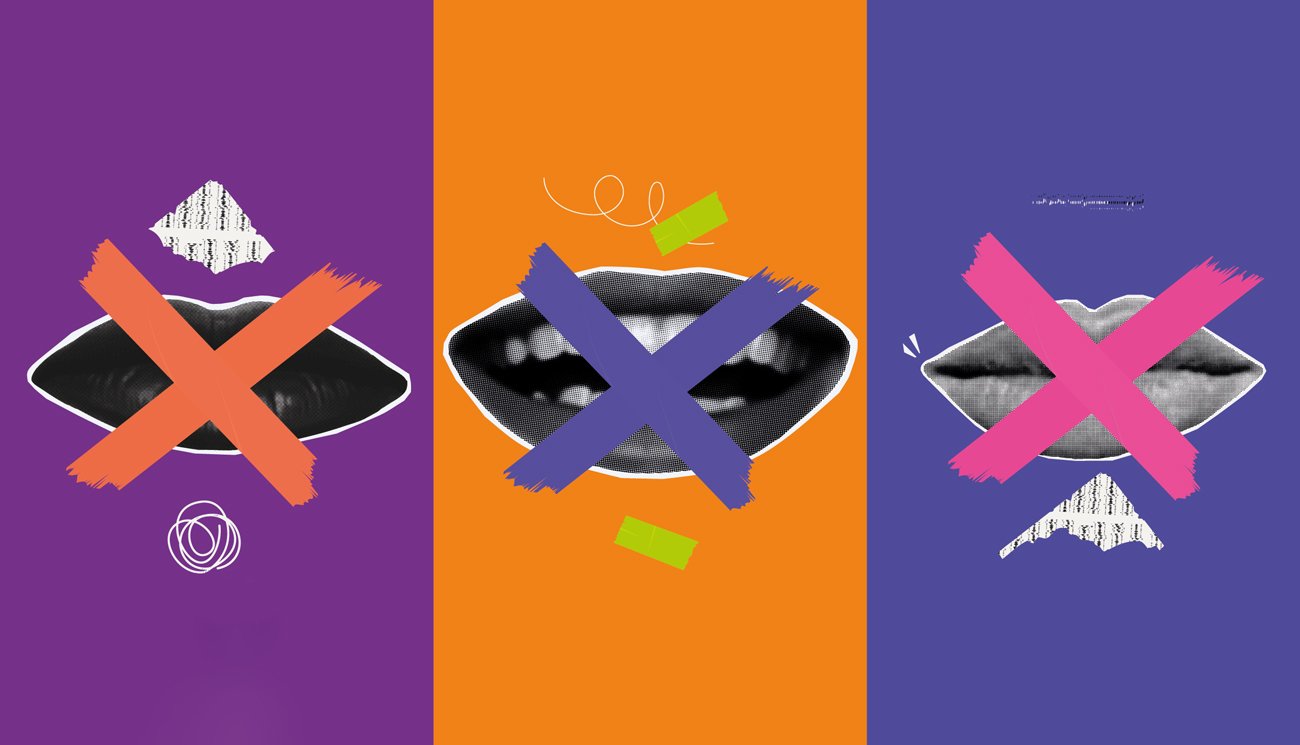

- Il video dell’uomo che in Germania getta a terra merce in un supermercato non c’entra con il RamadanIl video dell’uomo che in Germania getta a terra merce in un supermercato non c’entra con il Ramadan
- Questo video di un’esercitazione di soldati robot cinesi è falsoQuesto video di un’esercitazione di soldati robot cinesi è falso




