
Non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti
La ricerca di possibili precursori sismici non ha dato finora risultati, ma abbiamo già diversi strumenti per prepararci e ridurre i rischi
Quando accade un terremoto distruttivo la domanda che viene evocata è sempre la stessa: si poteva prevedere? L’interrogativo rimanda alla difficoltà che sperimentiamo nell’affrontare l’incertezza e l’impreparazione e i ritardi con cui spesso si gestiscono i rischi naturali.
Da mesi i residenti dei centri abitati che si trovano attorno ai Campi Flegrei, vicino a Napoli, sono afflitti da frequenti terremoti, alcuni anche di magnitudo sufficientemente alta da provocare panico e qualche danno. Si tratta di un’attività sismica legata al vulcanismo dell’area, a differenza del terremoto di magnitudo 7.7 che il 28 marzo ha provocato più di 3.000 morti accertati finora in Myanmar, che è stato causato dal movimento delle placche tettoniche in cui è divisa la crosta terrestre.
Sui terremoti circolano da sempre bufale, complottismi e disinformazione, dal presunto coinvolgimento del programma HAARP a profezie mai avverate. In Italia c’è stato il caso delle presunte previsioni del terremoto a L’Aquila del 2009, una vicenda che ha avuto conseguenze giudiziarie e ha scatenato polemiche sul ruolo degli esperti e delle istituzioni nella comunicazione del rischio.
Una ricerca finora senza risultati
La previsione dei terremoti è una specie di Santo Graal della sismologia, la scienza che studia i terremoti. Da più di 100 anni si cercano possibili precursori sismici, cioè fenomeni geologici, fisici, chimici annunciatori di terremoti. La deformazione del suolo, campi elettromagnetici, variazioni del flusso e del livello delle falde acquifere, segnali acustici, emissioni di gas sono i fenomeni su cui si è più concentrata l’attenzione. Ad oggi nessuno di questi ha dimostrato di avere una solida correlazione con i terremoti, tantomeno di poter essere utilizzato per allertare la popolazione in vista di un evento imminente, cioè che potrebbe accadere nell’arco di giorni, settimane o mesi.
Una delle principali difficoltà riguarda la definizione stessa di quello che dovrebbe costituire un precursore. Come riportava una revisione critica pubblicata nel 1997, un precursore sismico dovrebbe rispondere a dei criteri di convalida della sua efficacia. Per esempio, oltre a mostrare una precisa relazione con i meccanismi che generano i terremoti, un precursore dovrebbe essere osservato simultaneamente su più strumenti e dovrebbe mostrare una qualche relazione con la distanza con il luogo dove avviene la scossa principale e dovrebbero esserci delle regole per associare statisticamente uno o più di questi fenomeni ai terremoti futuri, sulla base di un grande numero di dati. Nessuno dei candidati-precursori ha mai finora soddisfatto questi criteri. Le associazioni, vere o presunte, sono sempre apparse deboli e contraddittorie o sono state avanzate dopo che i terremoti si erano già verificati. Gli stessi “sciami” sismici, sequenza di scosse di piccola intensità che possono susseguirsi per giorni o settimane, non possono funzionare come precursori sismici, perché non è detto che precedano di poco tempo un evento catastrofico.
Se si riflette su cos’è un terremoto e sui meccanismi da cui si originano si capisce perché sia così difficile prevederli. Un terremoto è il risultato dei movimenti delle placche in cui è suddivisa la crosta terrestre, cioè dei blocchi che scivolando gli uni sugli altri accumulano tensioni e attriti. Le aree più prossime alle faglie, ai margini delle placche, sono quelle dove si concentrano i terremoti, a partire da quelli più distruttivi.
La maggior parte delle scosse sismiche deriva dal rilascio improvviso dell’energia accumulata in queste aree della crosta terrestre, come risultato di un processo graduale che può andare avanti per molto tempo. Tuttavia, la reazione che si verifica in queste strutture, in risposta agli stress, non è lineare, cioè non è direttamente proporzionale. Si tratta di eventi improvvisi e accelerati e questa caratteristica è uno degli elementi che rende più arduo predire come possano svilupparsi. Possiamo migliorare la nostra comprensione di questi fenomeni, ma, in un certo senso, è proprio la loro natura complessa a complicare la possibilità di prevederli.
In natura esistono molti sistemi complessi e spesso siamo in grado di studiare gli elementi che li compongono attraverso modelli matematici, com’è il caso del clima e dei fenomeni meteorologici. Nel caso dei terremoti, la sfida scientifica è anche più impegnativa. Oggi gli scienziati sono in grado di definire le caratteristiche e i meccanismi di una sorgente sismogenetica, cioè di un’area della crosta terrestre che può sprigionare terremoti, e sono perfino in grado di misurare gli spostamenti delle grandi placche della crosta terrestre, ma questo non è sufficiente per prevedere un terremoto.
Affrontare e prevenire i rischi
Nei giorni scorsi, sui media, è circolata la notizia che uno studio del 2011 avrebbe “previsto” il terremoto in Myanmar, ma non si è trattato di una previsione deterministica. Gli scienziati avevano capito che lungo la faglia, nell’area che sarebbe stata poi colpita a marzo di quest’anno, c’era una “lacuna sismica” che indicava un’elevata probabilità che si verificasse un forte terremoto e sono stati in grado di stimare con precisione la sua magnitudo. Non hanno fatto una previsione, ma hanno individuato un rischio.
In genere, però, si pensa che prevedere un evento implichi proprio un’idea deterministica, cioè la possibilità di affermare quando e dove avverrà, all’interno di finestre spaziali e temporali piuttosto ristrette. Questo è il genere di previsione che, almeno ad oggi, non è possibile fare nel caso dei terremoti. Ciò che invece è possibile è una previsione probabilistica, che ha a che vedere con la nozione di rischio. La mappatura delle sorgenti sismiche, le reti di monitoraggio, la conoscenza dei terremoti avvenuti nel passato costituiscono la base per identificare le regioni più a rischio.
In Italia, nel 2004, è stata pubblicata la mappa di pericolosità sismica che classifica il territorio nazionale in quattro zone sulla base dell’intensità di scuotimento del suolo atteso a causa di un terremoto. Come spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), si tratta di una mappatura probabilistica, non di una previsione deterministica, nemmeno riguardo a quello che potrebbe essere il massimo terremoto possibile in un’area.
Questa mappa è però uno strumento cruciale, perché è la base per valutare il rischio sismico, cioè la stima del danno che ci possiamo attenderci in un luogo in seguito a un terremoto. La pericolosità riflette la sismicità intrinseca di una zona, cioè la sua propensione a originare terremoti di una certa magnitudo a causa delle sue caratteristiche geologiche. Il rischio è l’effetto non solo della pericolosità, ma anche della esposizione e della vulnerabilità, due fattori legati alla presenza umana e alla resistenza di strutture ed edifici.
Sappiamo che le aree più pericolose in Italia si trovano in Calabria, in Sicilia, nell’Appennino Centro-Meridionale e sulle Alpi Orientali, dove storicamente si sono verificati i terremoti più forti. Ma la grandissima parte del territorio nazionale è a rischio di terremoti di magnitudo potenzialmente elevata. È il caso della pianura padana, un’area che per molto tempo è stata considerata comunemente (ma non dai sismologi) poco interessata dai terremoti, una percezione sbagliata come hanno dimostrato gli eventi del 2012.
Anche se sembra paradossale, grazie alla definizione della pericolosità e del rischio sismici abbiamo un’idea piuttosto precisa di dove potrebbero avvenire i terremoti e persino della magnitudo che possiamo attenderci in aree diverse, ma questo non ci permette di restringere il campo a una scala temporale ristretta, dell’ordine di settimane, mesi e forse nemmeno anni. In un certo senso, quindi, le previsioni a lungo termine, nell’arco dei decenni, sono più solide delle previsioni a breve e medio termine, da giorni a mesi.
La ricerca scientifica, però, continua a ricercare modi e strumenti per migliorare la capacità di previsione. Nel 2024 sono stati pubblicati due studi, a cui ha contribuito l’Università di Parma, che suggeriscono che il ciclo sismico, cioè il graduale accumulo di energia che innesca un terremoto, possa modificare i movimenti delle placche tettoniche in modo tale da poter essere misurati a distanza attraverso reti di stazioni GPS. Non è nulla di simile a quei precursori sismici che sono stati cercati invano per un secolo e che dovrebbero prevedere un terremoto appena pochi giorni o settimane prima. Si tratta, piuttosto, di un insieme di segnali che potrebbero indicare la possibilità che avvenga un terremoto nell’arco di alcuni anni e a grandi distanze e le informazioni che si potrebbero ricavare si potrebbero sfruttare per mitigare il rischio sismico.
Ci sono poi sistemi di allerta precoce, come quello chiamato ShakeAlert, realizzato dallo United States Geological Surveys, il servizio geologico degli Stati Uniti. È in grado di rilevare un terremoto e avvisare la popolazione con alcuni secondi di anticipo attraverso avvisi via radio, televisione e cellulare. Questo sistema è attivo in California, Oregon e Stato di Washington, regioni di elevata pericolosità sismica negli Stati Uniti, e raggiunge un bacino di 50 milioni di persone. “Alcuni secondi” sono pochi, ma sufficienti a salvare vite umane. Sistemi simili vengono sperimentati anche in altri Paesi, tra cui l’Italia.
Anche nel caso dei terremoti di origine vulcanica si stanno facendo passi in avanti. Di recente L’INGV ha presentato i risultati del monitoraggio termico dell’area dei Campi Flegrei. Grazie ai dati trasmessi da ECOSTRESS, un sensore installato sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli scienziati hanno rilevato variazioni della temperatura nell’area della Solfatara di Pozzuoli, uno dei vulcani dei Campi Flegrei. Queste anomalie hanno preceduto di pochi giorni o settimane alcuni dei terremoti di maggiore intensità, perciò potrebbero costituire dei segnali utili per la prevenzione del rischio.
Non sappiamo se la scienza sarà mai in grado di dirci con precisione il luogo e il giorno in cui una ristretta area geografica sarà l’epicentro di un terremoto. Probabilmente, no. Ma abbiamo già abbastanza strumenti per affrontare questi rischi, prepararci e prevenirli, attraverso innanzitutto la messa in sicurezza di un patrimonio edilizio che, in Italia, è spesso fragile ed esposto ad altri pericoli, oltre ai terremoti. Questa responsabilità non riguarda direttamente gli scienziati, ma anche, e soprattutto, la società nel suo complesso.
- La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online
 La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online
La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online - Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump
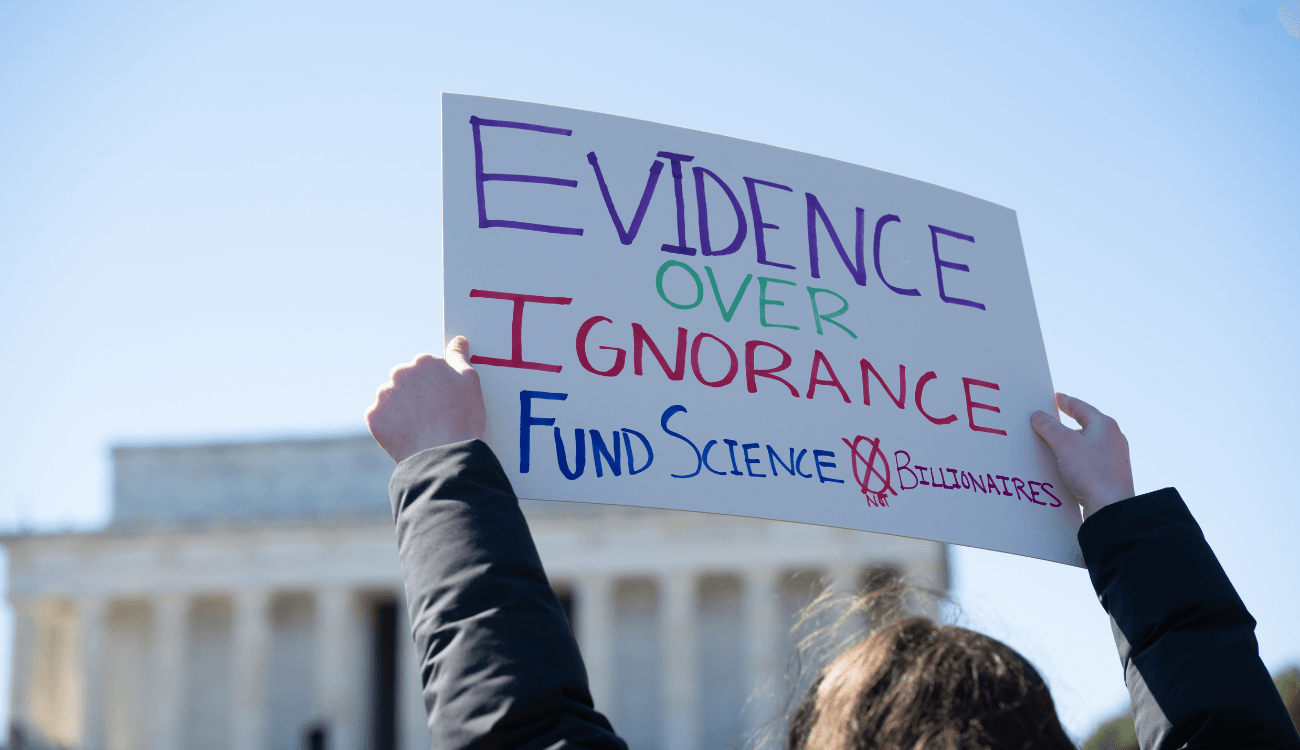 Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump
Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump
