

Perché fidarsi di Big Pharma, e perché no: domande e risposte
[…]
Aggiornamento al 28 maggio 2021: Abbiamo precisato che il prezzo dei farmaci dipende anche dalla contrattazione con le agenzie
Nelle discussioni su vaccini, medicina ufficiale e medicina alternativa si incontra sempre un personaggio ingombrante: stiamo parlando della cosiddetta Big Pharma, le grandi case farmaceutiche a cui in gran parte, volenti o nolenti, dobbiamo i farmaci e i vaccini su cui si fondano terapie e prevenzione.
Non stiamo certo parlando di enti di beneficenza: quello farmaceutico è un giro d’affari immenso, valutato nel 2020 in 1.270 miliardi di dollari a livello mondiale. È inevitabile quindi che intorno a Big Pharma sorgano teorie del complotto e diffidenze.
Ma dobbiamo quindi ciecamente fidarci dell’industria farmaceutica, o gli scettici hanno ragione a rifiutarla? La realtà, come spesso accade, è più complessa. In questo approfondimento proviamo a rispondere ad alcuni dei principali quesiti che riguardano il rapporto tra industria farmaceutica e salute pubblica.
Come è nata Big Pharma? Quanto sono indipendenti da essa gli studi scientifici di cui sentiamo spesso parlare? Come viene stabilito il prezzo di un farmaco? È possibile avere fiducia nella medicina ufficiale ma essere allo stesso tempo critici nei confronti di un’industria che, nel bene e nel male, condiziona le nostre vite? La risposta è, nonostante tutto, sì. Scopriamo perché.
Come (e quando) è nata l’industria farmaceutica?
Cominciamo dall’inizio e torniamo indietro di qualche decennio.
L’industria farmaceutica è nata nella seconda metà del XIX secolo a partire da due filoni in origine distinti: da un lato, farmacisti e speziali che hanno progressivamente iniziato a produrre sostanze farmaceutiche in massa come morfina, chinino e stricnina. Parliamo, ad esempio, dei progenitori dell’attuale società farmaceutica Merck, che in origine era una farmacia di Darmstadt (Germania) fondata nel lontano 1668. D’altra parte c’era invece l’industria chimica, che a metà Ottocento muoveva i suoi primi passi: accadeva spesso che aziende nate per la produzione di altre sostanze, come i coloranti, cominciarono ad espandersi anche nel campo farmaceutico. È, ad esempio, il caso di Sandoz (ora Novartis) o Bayer. Alla fine del XIX secolo le realtà appartenenti ad entrambi i filoni sono decollate grazie alla nascente ricerca chimica e farmaceutica, campo in cui spicca la figura di Paul Ehrlich, uno dei primi ricercatori a comprendere che esisteva una relazione tra la struttura chimica e l’attività biologica di un composto farmacologico e che era possibile progettare farmaci in modo razionale.
Benché l’industria farmaceutica sia stata in pressoché costante espansione dall’inizio del XX secolo, la vera Big Pharma – intesa oggi come l’insieme di conglomerati multinazionali in cui relativamente poche aziende controllano l’industria col rischio di un controllo economico e politico – è nata solo tra il 1985 e il 2005, grazie ad una serie di fusioni e acquisizioni tra le protagoniste del mercato. Nonostante le fusioni che a partire dagli anni Ottanta hanno caratterizzato il settore, in tempi recenti la situazione è piuttosto frammentaria: nel 2019 le prime dieci aziende farmaceutiche avevano segmenti di mercato relativamente piccoli e confrontabili, compresi tra il 3,6 e il 5,5 per cento.
Efficacia e sicurezza dei farmaci: che evoluzione c’è stata?
Fin dalle origini, l’espansione dell’industria farmaceutica è andata di pari passo con la necessità di garantire sicurezza ed efficacia dei farmaci. Una delle prime regolamentazioni sulla sicurezza farmaceutica è stato il Biologics Control Act del 1902 emanato negli Stati Uniti e approvato in seguito a un incidente in cui un farmaco contro la difterite, accidentalmente contaminato dal bacillo del tetano, causò il decesso di 13 bambini.
Questo episodio fa in realtà da esempio ad uno schema che, negli anni, si ripeterà spesso: accade un incidente e in risposta vengono introdotti nuovi regolamenti, anche sull’onda dell’opinione pubblica.
Facciamo qualche altro esempio: prima del “disastro della sulfanilamide” del 1937, in cui uno sciroppo antibiotico mai testato per la sicurezza o l’efficacia uccise più di cento persone a causa di un ingrediente tossico (il glicole dietilenico), non era obbligatorio testare e garantire la sicurezza dei farmaci. A partire da questo episodio la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha sempre richiesto i dati di test preclinici e clinici prima di approvare un medicinale.
Tra il 1943 e il 1946 sono stati introdotti in Inghilterra i primi studi clinici a doppio cieco (il che, ricordiamo, significa che né il medico che somministra il trattamento né il paziente sanno a priori se si tratta del medicinale o del placebo). Nei decenni seguenti diventeranno lo standard per la sperimentazione dei farmaci.
Più di recente, uno degli incidenti più drammatici è stato quello che ha provocato migliaia di nascite di bambini malformati causate dalla talidomide (un sedativo usato contro le nausee in gravidanza) negli anni ‘50-’60 del XX secolo. A questo incidente da una parte i legislatori risposero stringendo i criteri per la sperimentazione dei farmaci e, dall’altra, le industrie farmaceutiche iniziarono ad investire sempre di più in test clinici e preclinici, allargando ad esempio i campioni di pazienti per i test e cercando di garantire una sempre maggiore affidabilità. La medicina in seguito ha imparato a usare un approccio sempre più scientifico: può sorprendere, ma fino agli anni ‘80 del secolo scorso non era scontato sfruttare le migliori prove scientifiche a disposizione e ciò accadeva perché medici – pur studiando la letteratura medica e scientifica – si facevano una propria opinione, ma non c’era alle spalle un approccio rigoroso come quello di oggi.
Il grande cambiamento è avvenuto tra gli anni ‘80 e ‘90 del XX secolo con quella che viene chiamata la evidence-based medicine (Ebm), la medicina basata sulle prove di efficacia. Nelle parole di David L. Sackett, pioniere della Ebm, stiamo parlando dell’ «uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori prove a disposizione nel prendere decisioni sulla cura dei singoli pazienti», integrando la propria esperienza con la migliore ricerca clinica, analizzata sistematicamente e rigorosamente. In questo modo, valutando i dati scientifici che derivano da numerosi studi, ad esempio attraverso analisi statistiche come le metanalisi (che, però, non sono infallibili), si possono proporre le terapie che si sono dimostrate più efficaci alla prova dei fatti.
Uno dei principali organismi della Ebm è la Cochrane Collaboration, organizzazione no-profit internazionale nata per «preparare, aggiornare e disseminare revisioni sistematiche degli studi clinici controllati» o, se non ci sono studi clinici controllati, «revisioni sistematiche delle evidenze comunque esistenti». La Ebm, riportando la medicina in un alveo il più possibilmente scientifico, ha condotto a numerosi miglioramenti delle terapie disponibili.
Gli studi scientifici sono indipendenti o vengono influenzati da Big Pharma?
Poco sopra abbiamo parlato della volontà di utilizzare le «migliori prove a disposizione» come approccio base della ricerca scientifica. Ma cosa accade quando i legami tra ricercatori e rispettivi studi e aziende farmaceutiche sono piuttosto stretti?
Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda ricordando, come abbiamo raccontato su Facta, che le evidenze scientifiche non si possono quasi mai basare su un singolo studio, perché, specie in ambito biologico e medico, ci sono numerosi fattori sia casuali sia non che possono introdurre errori o distorcere i risultati. Tra questi, rientrano anche i fondi che finanziano gli studi stessi. Ci sono infatti numerose analisi che mostrano come gli studi medici finanziati da un’industria tendano, non sorprendentemente, a essere favorevoli all’industria stessa: è per esempio successo per la ricerca sul tabacco, sugli antidepressivi o, ancora, sullo zucchero.
Ricordiamo poi che le aziende farmaceutiche possono influenzare direttamente gli stessi medici tramite diversi tipi di incentivi economici inducendoli a prescrivere i farmaci da loro sponsorizzati. Questo è un problema riconosciuto quando si tenta, secondo l’Ebm, di raccogliere e valutare le migliori prove scientifiche su un trattamento medico, e c’è chi argomenta che bisognerebbe rendere gli studi clinici del tutto indipendenti dalle case farmaceutiche per scongiurare episodi simili a quelli di cui abbiamo appena parlato.
Qual è il miglior modo di incentivare lo sviluppo dei farmaci?
Oggi l’industria farmaceutica fonda il suo sviluppo sui brevetti. Questi introducono di fatto un regime di monopolio, sia pure temporaneo, su un farmaco, permettendo alle case farmaceutiche di avere l’esclusiva e determinarne il prezzo arbitrariamente, in modo da rientrare dei costi sostenuti per lo sviluppo. La giustificazione dell’industria farmaceutica è che i brevetti sono indispensabili per sostenere l’innovazione necessaria alla ricerca farmaceutica, innovazione molto rischiosa: meno del 12 per cento dei farmaci che accedono alle sperimentazioni cliniche arriva poi sul mercato, con una spesa di 2,6 miliardi di dollari per farmaco.
La questione però è discussa: non è del tutto chiaro se i brevetti siano il miglior meccanismo per finanziare la ricerca e l’industria farmaceutica, e le case farmaceutiche tentano costantemente strategie non sempre del tutto etiche (come brevettare modifiche irrilevanti) per estendere la durata dei brevetti e assicurarsi un monopolio a tempo indefinito. Inoltre, il sistema di incentivi economici per l’industria farmaceutica non risponde sempre alle esigenze della salute pubblica.
Il caso più eclatante è probabilmente quello dello sviluppo degli antibiotici: le infezioni da batteri patogeni resistenti agli antibiotici sono un’importante causa di malattia e morte (solo in Italia causano circa 10.000 decessi all’anno e sono considerate dall’Oms una delle «più grandi minacce alla salute globale»). Le case farmaceutiche però non investono per ricercare nuovi antibiotici, in quanto il ritorno economico sarebbe troppo limitato.
Chi stabilisce il prezzo di un farmaco?
È difficile determinare quale sia il prezzo onesto per un farmaco. Anche se il prezzo dei medicinali viene contrattato con le agenzie nazionali, ci sono però diversi casi di aumenti discutibili del prezzo dei farmaci che viene pagato dalla sanità pubblica o dai pazienti con il rischio di mettere in crisi i sistemi sanitari. Proprio per questo nel 2018 l’Unione europea ha sollevato la questione davanti all’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, realtà internazionale che si occupa di coordinare e confrontare le politiche economiche di 38 Paesi (tra cui pressoché tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone). Un caso esemplare è quello dell’anticorpo Soliris (eculizumab), unico trattamento per una rara malattia genetica, che nel 2014 poteva costare fino a 440.000 dollari l’anno per ogni paziente, un prezzo che non sembra giustificato dai costi sostenuti per lo sviluppo e la produzione, secondo ricercatori ed esperti dell’industria farmaceutica. In Canada, per esempio, nel 2017 l’organismo governativo preposto al controllo del prezzo dei farmaci ha concluso che il prezzo del Soliris era eccessivo, costringendo l’azienda produttrice anche a risarcimenti.
Il Kalydeco (ivacaftor), farmaco usato per il trattamento della fibrosi cistica, è stato sviluppato dall’azienda privata Vertex grazie ad una collaborazione con una fondazione di beneficenza a favore della fibrosi cistica, ma è diventato uno dei farmaci più cari del mondo. Il prezzo è intorno a 300.000 dollari all’anno per un regime di due pillole al giorno, costo che è stato giudicato eccessivo dagli stessi medici e ricercatori coinvolti nello sviluppo. Più recentemente, a maggio 2021, la Commissione parlamentare di vigilanza del Congresso degli Stati Uniti ha messo sotto accusa l’azienda biotecnologica AbbVie, produttrice di Humira (adalimumab), il farmaco più redditizio del mondo, per averne alzato il prezzo del 470 per cento senza una giustificazione in termini di costi o di investimenti in ricerca e sviluppo.
I farmaci, bene pubblico o privato?
Il 24 marzo 2021 Boris Johnson ha dichiarato che lo sviluppo dei vaccini contro la Covid-19 è stato dovuto al «capitalismo e all’avidità», riferendosi al successo delle case farmaceutiche in un regime di libero mercato. In realtà le cose non sono sempre così chiare. Un esempio di questa complessità sono i vaccini contro la Covid-19 prodotti da aziende private, ma solo grazie a enormi investimenti pubblici.
Secondo uno studio disponibile come preprint, fino al 97 per cento dei fondi necessari allo sviluppo del vaccino AstraZeneca sono stati forniti da fondi pubblici o enti benefici. BioNTech, l’azienda con cui Pfizer ha sviluppato il vaccino, ha ricevuto un totale di 475 milioni di euro dal governo tedesco e dall’Unione europea. Il tutto senza contare i contratti di acquisto anticipato con cui ad esempio l’Unione europea si impegnava a comprare milioni di dosi di vaccino dai produttori, prima ancora di avere certezza della loro efficacia e sicurezza, allo scopo di mitigare il rischio per le aziende. In generale, anche prima dello sforzo eccezionale dovuto alla pandemia, c’era un sostanziale contributo della ricerca pubblica, in termini di conoscenze e sviluppo tecnologico, allo sviluppo dei farmaci messi poi sul mercato da aziende private.
È vero che in questo scambio guadagnano entrambi i lati: da una parte i governi hanno ottenuto i vaccini anti-Covid, grazie agli impianti di produzione e know-how delle aziende, e dall’altro le aziende hanno ricevuto un guadagno economico e si sono garantite ordini di vaccini a lungo termine. Resta però la contraddizione di un pubblico che ha investito moltissimo e di privati che si tengono il frutto di tali investimenti, soprattutto in termini di proprietà intellettuale (i brevetti), che impediscono alla concorrenza di produrre e commercializzare lo stesso farmaco. Questo può ostacolarne la produzione il relativo accesso alle cure a basso costo nei Paesi in via di sviluppo.
La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere questo tema a livello internazionale. Tra gli altri, Winnie Byanyima – sottosegretaria generale dell’Onu e direttrice esecutiva del programma Onu su Hiv/Aids – ha chiesto già a novembre 2020 alle case farmaceutiche di condividere le tecnologie sui vaccini e rinunciare ai brevetti per permettere la libera produzione di vaccini, una posizione ora sostenuta anche dal governo degli Stati Uniti.
Va precisato che non è chiaro quanto, in pratica, tale sostegno possa cambiare la situazione: probabilmente sarebbe stato più utile sollevare la questione molti mesi prima. C’è anche chi è scettico sulla necessità di rimuovere o sospendere i brevetti (tra cui le case farmaceutiche stesse), in quanto il principale ostacolo alla produzione di vaccini sarebbero semmai le materie prime e il know-how necessario alla produzione, e le case farmaceutiche avrebbero preso accordi con pressoché tutti gli impianti di produzione per i vaccini.
Perché continuare a fidarsi delle industrie farmaceutiche?
Alla fine di questa rassegna su alcune delle principali questioni che riguardano Big Pharma, ci si potrebbe domandare allora se non abbia ragione chi decide di essere scettico sui vaccini o altre terapie.
La risposta è che non dobbiamo fidarci di Big Pharma in sé, ma semmai dei numerosi meccanismi di controllo che a ogni passo verificano l’efficacia e la sicurezza di quanto viene prodotto. In altre parole, la medicina “ufficiale” può funzionare grazie a quello scetticismo organizzato, per usare l’espressione del sociologo della scienza Robert K. Merton, secondo cui «qualsiasi cosa può e deve essere messa in discussione, criticata, modificata o rigettata, in un processo infinito di revisione continua dove non trovano spazio il dogma o la fede».
Di continuo costretta a dimostrare sicurezza ed efficacia dei propri prodotti, l’industria farmaceutica – sostenuta dalla ricerca scientifica di base – ha riscosso indiscutibili successi, dai vaccini agli antibiotici, dalle terapie antitumorali, alle terapie contro Hiv/Aids.
Benché le medicine “non convenzionali” o “alternative” si presentino spesso come una sfida scettica a una presunta ortodossia della comunità scientifica e industriale, la verità è che svicolano dai controlli che rischiano di metterle in dubbio, diventando quindi esse stesse atto di fede. Lo abbiamo visto durante la pandemia da Covid-19: i fautori delle terapie domiciliari, per esempio, spesso non portano prove incontrovertibili delle loro teorie, bensì rifiutano proprio gli standard di qualità, come gli studi clinici in doppio cieco, che ne dimostrano l’inefficacia.
A tale proposito anche l’idea – di per sé magari complottista, ma a priori non assurda – che cure economiche e non protette da brevetti vengano messe da parte a favore di terapie costose spinte dalle case farmaceutiche, cade proprio di fronte alle analisi della comunità scientifica. Ad oggi (maggio 2021), gli unici due farmaci considerati in qualche modo utili contro la Covid-19 dalla comunità scientifica sono farmaci disponibili senza brevetto: i corticosteroidi come il desametasone (economico e liberamente disponibile), e la colchicina (un farmaco estratto dalle piante noto fin dall’antichità e usato per gli attacchi di gotta fin dal XVIII secolo). Viceversa il remdesivir, farmaco tuttora di proprietà della azienda farmaceutica Gilead Sciences, non è considerato efficace. Ironicamente, gli sforzi per garantire la sicurezza dei farmaci a volte vengono usati per screditarli: gli scettici dei vaccini usano in modo errato, per tentare di dimostrarne la pericolosità, i database di sorveglianza che servono proprio a verificarne costantemente la sicurezza.
È certamente vero, come ha mostrato il caso Emaleaks, che le agenzie di controllo sono sottoposte a pressioni politiche ed economiche ma gli stessi documenti trafugati dagli hacker che hanno evidenziato l’esistenza di tali pressioni hanno anche mostrato che tali agenzie sono consapevoli della loro responsabilità e possono resistere a tali pressioni. Quanto accaduto a marzo 2021 con le questioni di sicurezza intorno al vaccino anti-Covid di AstraZeneca, nonostante un innegabile fallimento comunicativo, ha anche dimostrato che tali agenzie hanno investigato prontamente e apertamente anche effetti collaterali di per sé molto rari.
In conclusione
Dobbiamo molto ai farmaci prodotti da Big Pharma per la nostra salute, ma questo non vuol dire che si tratti di un ente benefico di cui fidarsi a priori. Ci sono ancora molti punti critici e questioni da risolvere nel rapporto tra industria farmaceutica, sistema economico, ricerca scientifica e salute pubblica. Ma invece di demonizzare o accettare acriticamente quanto viene fuori dall’industria farmaceutica, è bene chiedersi su quali aspetti ci si può fidare, e su quali mantenere un certo scetticismo. Può essere giusto, ad esempio, fidarsi in generale dell’efficacia dei vaccini, su cui esistono numerosissimi dati indipendenti; ma può essere legittimo non fidarsi di un comunicato stampa o di un singolo studio sponsorizzato da un’azienda farmaceutica che promette miracoli.
Se le contraddizioni di Big Pharma sono un problema, le medicine alternative però sono la risposta sbagliata. Le basi scientifiche, gli studi clinici, e i controlli a cui devono sottoporsi i farmaci sono la migliore garanzia che abbiamo della sicurezza ed efficacia della medicina, garanzia che le cure alternative non hanno.

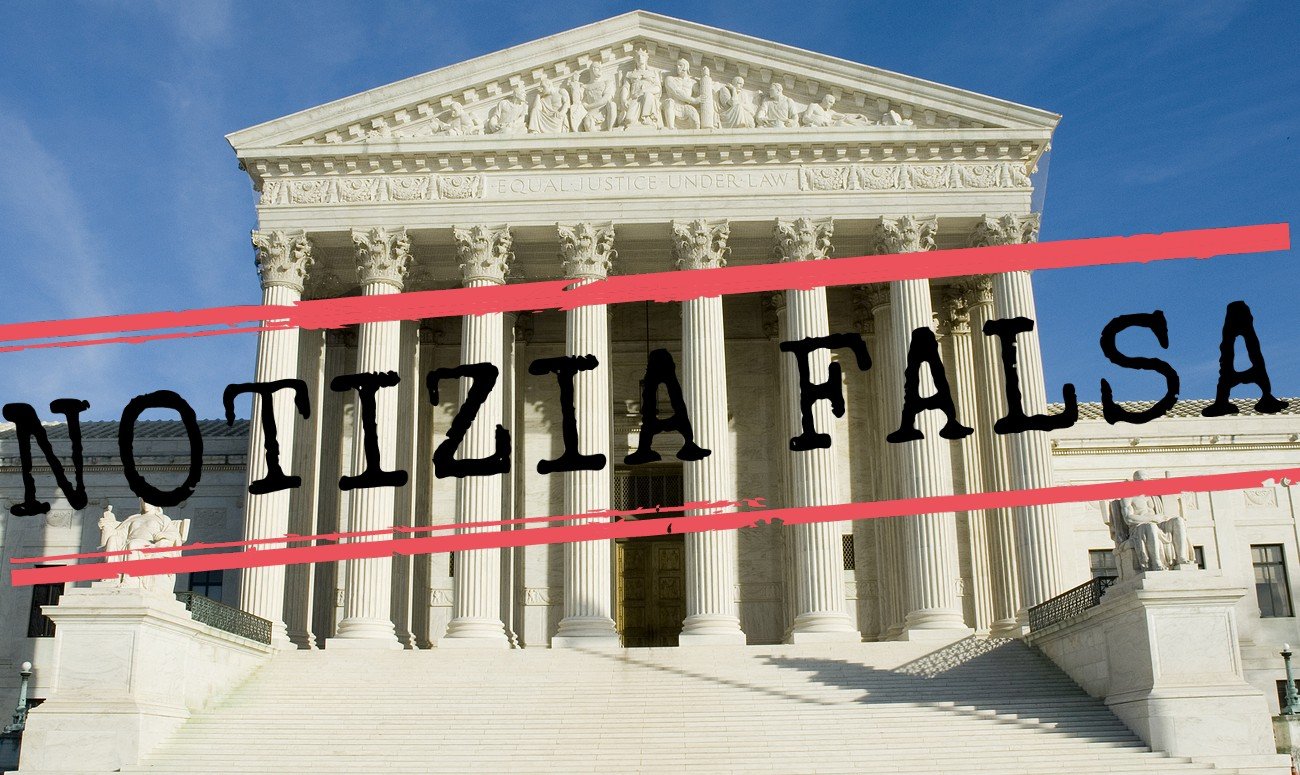
- No, in Iran non è stato esposto un cartonato di Mojtaba Khamenei il giorno della sua elezione come guida supremaNo, in Iran non è stato esposto un cartonato di Mojtaba Khamenei il giorno della sua elezione come guida suprema
- Il nostro pessimo dibattito pubblico sull’aborto dipende anche da dati ufficiali scadenti
 Il nostro pessimo dibattito pubblico sull’aborto dipende anche da dati ufficiali scadenti
Il nostro pessimo dibattito pubblico sull’aborto dipende anche da dati ufficiali scadenti




