
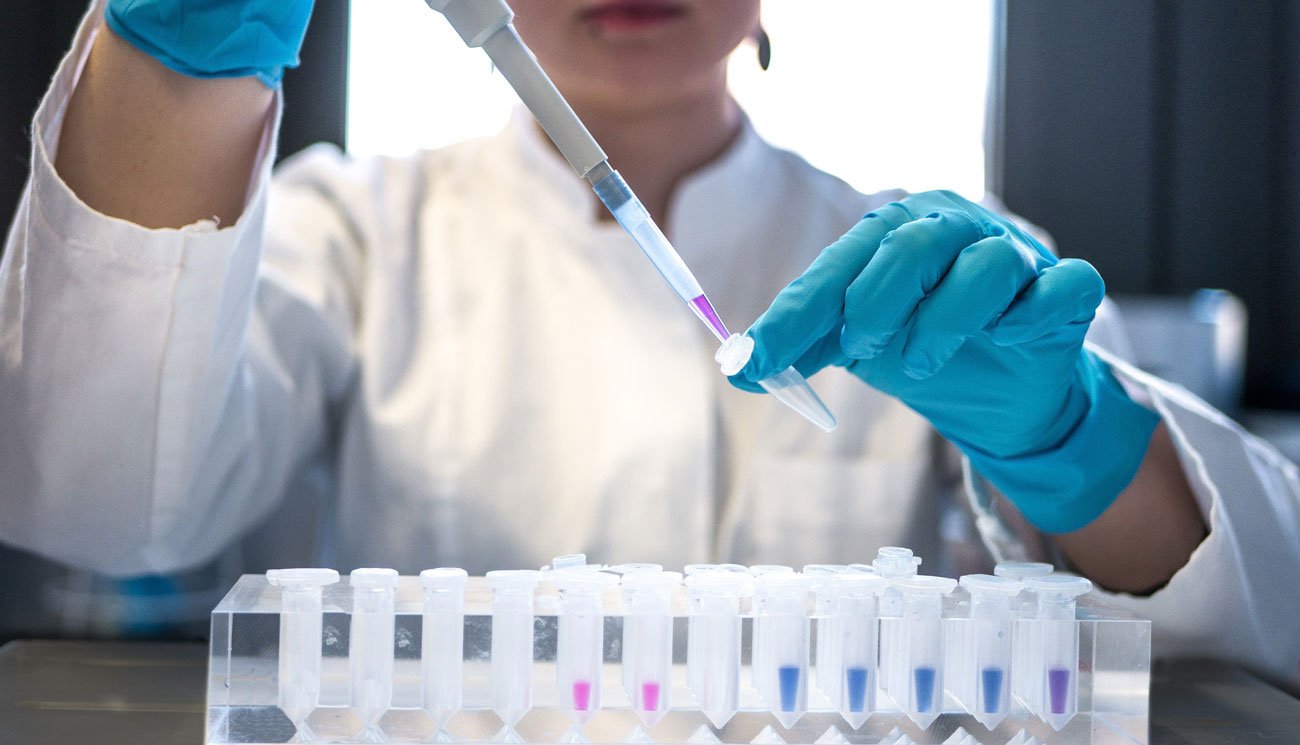
Dietrofront! Quando la scienza sulla pandemia ha cambiato idea
[…]
Il bombardamento di informazioni sulla pandemia è stato ed è difficile per tutti da navigare: uno degli obiettivi di Facta è proprio quello di mettere ordine. Ma in mezzo alle notizie false o senza prove ci sono stati anche casi in cui, effettivamente, la scienza ha detto una cosa, per poi dire tempo dopo il suo contrario. Vuol dire che non possiamo fidarci della scienza? Sorprendentemente, è proprio il contrario: vuol dire che la scienza sa correggere i propri errori. Vediamo alcuni casi in cui, durante la pandemia, la scienza ha cambiato idea e perché, e che cosa abbiamo imparato.
Mascherine no, mascherine sì
Può sembrare assurdo oggi, ma c’è stato un breve momento, all’inizio della pandemia, in cui non era raccomandato l’uso delle mascherine se non in circostanze molto specifiche.
La prima linea guida dell’Oms sulle mascherine è del 29 gennaio 2020, quando ancora il virus Sars-CoV-2 si chiamava 2019-nCov e la malattia non era stata battezzata Covid-19. In queste linee guida si legge che le mascherine da sole non bastano a proteggere e che erano raccomandate solo a persone con evidenti sintomi respiratori e agli operatori sanitari. Secondo l’Oms, all’epoca, «indossare mascherine quando non è indicato può portare a costi inutili, problemi di approvvigionamento e creare un falso senso di sicurezza che può far dimenticare altre misure essenziali, come l’igiene delle mani». La linea guida era anche parecchio confusa, in quanto non era chiaro se le mascherine proteggessero chi le indossa o gli altri (o entrambi), né perché fossero indicate solo in alcuni casi e non in altri.
La comunità scientifica era scettica sulle mascherine principalmente perché temeva un fenomeno noto come “compensazione del rischio”: l’idea che, se prendiamo una precauzione contro un pericolo, questa ci induce a essere meno cauti in altri comportamenti. Le mascherine quindi ci darebbero un senso di falsa sicurezza, portandoci a essere meno attenti: questo ne annullerebbe i vantaggi o addirittura aumenterebbe i nostri rischi.
Non è un’ipotesi del tutto campata in aria, ma già prima della pandemia sapevamo che non trova riscontro in molte circostanze e non può essere usata come un argomento contro le misure di sicurezza. Insomma, un timore in gran parte infondato che ha rallentato l’uso di una protezione, invece, efficace – anche se purtroppo al centro di diversi casi di disinformazione. Una meta-analisi pubblicata sul British Medical Journal il 18 novembre 2021 e che analizza numerosi studi condotti sulle mascherine ha calcolato che, in media, il loro uso riduce l’incidenza di Covid-19 di quasi il 50 per cento.
Il pericolo era nell’aria, ma non lo sapevamo
Strettamente legato al dietrofront sulle mascherine è quello sulla diffusione del virus. Ormai è istintivo per molti di noi ricordare che il virus si diffonde per via aerea: non solo le mascherine sono fondamentali, quindi, ma in un locale chiuso il distanziamento conta poco, ventilare è importante, e così via. C’è però voluto del tempo per capirlo, e per troppo tempo abbiamo ignorato dati importanti.
Alla fine di marzo 2020 l’Oms dichiarava perentoriamente che «la Covid-19 non si trasmette per via aerea». L’unica via di trasmissione del virus sarebbero state le goccioline (“droplets”) di saliva relativamente grandi, che cadono velocemente a terra ma possono rimanere appiccicate alle mani o alle superfici. Da qui il consiglio di lavarsi spesso e bene le mani, che tutti ricordiamo nella prima ondata di pandemia (e che resta una buona idea). L’Oms avrebbe cambiato idea intorno a maggio 2021, quando ormai era fin troppo chiaro che invece anche le ben più piccole particelle di aerosol, emesse dal fiato e capaci di viaggiare nell’aria a vari metri di distanza, possono trasmettere il virus.
Numerosi ricercatori esperti nella diffusione di particelle nell’aria infatti avevano già sospettato dai primi mesi della pandemia che gli aerosol fossero i veri responsabili. Tanto che il 6 luglio 2020 era stata pubblicata sulla rivista accademica Clinical Infectious Diseases una lettera firmata da 239 accademici, che chiedeva alla comunità scientifica di riconoscere – davanti a evidenze scientifiche ormai impossibili da ignorare – che Sars-CoV-2 si diffondeva anche per via aerea. L’Oms ha ceduto solo oltre un anno dopo, il 30 aprile 2021.
Perché allora parte della comunità medico-scientifica, inclusa l’Oms, si rifiutò di accettare le evidenze sul virus trasmesso per via aerea? Tra i motivi c’è stato anche, sorprendentemente, un equivoco sulla definizione di «trasmesso per via aerea» derivato da un libro degli anni Cinquanta del XX secolo, e faticosamente corretto solo durante la pandemia. La storia completa è un piccolo e affascinante “giallo” scientifico, nonché un esempio di come discipline scientifiche diverse come medicina e fisica fatichino a parlarsi, ed è stata raccontata bene da Wired, ma la riassumiamo in poche parole.
In un autorevole testo del 1955 venivano descritti esperimenti che mostravano come la tubercolosi si trasmettesse per via aerea solo tramite particelle più piccole di 5 micron (millesimi di millimetro), capaci di permanere in aria per moltissimo tempo. Questa soglia però riguardava solo la tubercolosi, che ha la peculiarità di richiedere che i batteri penetrino fino in fondo ai polmoni.
In realtà di norma anche particelle ben più grandi, fino a 100 millesimi di millimetro, possono trasmettere patogeni per via aerea. Cosa che faceva ben presente lo stesso libro. Eppure questo ultimo dato è stato per qualche motivo dimenticato dalla comunità medica, che invece ha ripetuto e accettato fuori contesto per decenni la soglia dei 5 micron per la trasmissione aerea. Siccome non c’erano prove che Sars-CoV-2 potesse permanere in aria in particelle così piccole, per molto tempo l’Oms e vari medici hanno semplicemente rifiutato l’idea che il virus si trasmettesse per via aerea.
Chiudere sembrava impossibile
Ricorderemo tutti per sempre il lockdown della prima ondata: il 9 marzo 2020 il governo Conte mise in atto il primo lockdown in Italia, che sarebbe finito solo il 4 maggio con la «fase 2», al calo della prima ondata di pandemia. Fu una misura drastica e sofferta, ma i lockdown in Italia e altri Paesi hanno probabilmente salvato, in totale, milioni di vite. Oggi numerosi studi (che abbiamo citato ad esempio qui) hanno dimostrato che lockdown e altre restrizioni, per quanto dolorose, sono state efficaci nel contenere la pandemia.
Non tutti i ricercatori però, quando iniziò a fare capolino Sars-CoV-2, erano d’accordo con l’efficacia di quarantene e lockdown. Commentando il lockdown di Wuhan in Cina, il 27 gennaio 2020, il professore di storia della medicina Howard Markel si preoccupava sulle pagine del New York Times che in realtà i lockdown fossero misure troppo drastiche e allo stesso tempo non molto efficienti. La stessa opinione era stata offerta da diversi ricercatori a Scientific American pochi giorni prima. Tra questi, il bioeticista Arthur Caplan affermò perentoriamente «Non è possibile mettere in quarantena la città di New York, giammai»: il clima politico e culturale non lo avrebbe permesso. Due mesi dopo, New York era in lockdown.
Quando le mutazioni del virus non ci preoccupavano
Alfa, delta, omicron: oggi gran parte della discussione sulla pandemia ruota intorno alle varianti di Sars-CoV-2 che si evolvono, spesso più capaci a diffondersi e quindi più pericolose, e che potrebbero ridurre l’efficacia dei vaccini. Ma una volta gli scienziati cercavano di rassicurarci, convinti che la probabilità di varianti più pericolose fosse minima.
Per esempio, il 31 gennaio 2020 il ricercatore in malattie infettive Kristian Andersen dichiarava a Nature che, sebbene sia normale che i virus mutino, «non conosco esempi» in cui un patogeno fosse diventato più virulento durante una pandemia, e che di norma le mutazioni non cambiano la trasmissione o la pericolosità del virus. Poco tempo dopo, il 18 febbraio 2020, Nature Microbiology pubblicava un editoriale intitolato “Non dovremmo preoccuparci quando un virus muta durante un’epidemia”. Ancora il 17 luglio 2020 Burtram Fielding, virologo specializzato in coronavirus dell’Università di Western Cape (Sudafrica) affermava di credere che «i virus tendono a diventare meno patogenici» (anche se altri ricercatori intervistati nello stesso articolo della rivista dell’Istituto Smithsonian erano di opinione diversa).
Di sicuro oggi sappiamo che non è vero che i virus diventano per forza “più buoni” evolvendosi, una bufala che purtroppo continua a essere ripetuta. Sars-CoV-2, come sappiamo, ha mostrato di evolversi ripetutamente, diventando sempre più contagioso. Nel 2021 le varianti alfa e delta hanno guidato le ondate della pandemia, mentre adesso omicron sta preoccupando la comunità scientifica. Quest’ultima variante, a causa del grande numero di mutazioni che la distingue dalle precedenti, potrebbe sfuggire in parte ai vaccini, anche se al momento non ci sono dati significativi né a favore né contro. Un fenomeno che era stato previsto, in realtà, già prima della campagna vaccinale (ma ricordiamo che è falso che le varianti siano una conseguenza dei vaccini).
La scienza sa dire “ho sbagliato”
Leggere questa serie di ripensamenti può indurci al pessimismo. Se la scienza si è sbagliata così tante volte, allora vuol dire che non possiamo fidarci di nulla di quanto dice? Che tutto potrebbe cambiare domani?
Non è così. Come funziona il progresso nella ricerca scientifica non si può riassumere in poche righe: è un tema estremamente sottile e complesso, che ha occupato e occupa tuttora una branca della filosofia nota come epistemologia. Quello che possiamo dire però è che, specialmente di fronte a un evento del tutto inedito quale una pandemia globale in una civiltà tecnologica come la nostra, dovuta a un virus nuovo, la scienza ha lavorato a enorme velocità tentando di interpretare e prevedere gli eventi. È inevitabile che, specie nelle prime fasi, vi siano stati errori: non si possono pretendere sempre risposte certe e immutabili.
Abbiamo visto però che la scienza ha corretto rapidamente i suoi errori (anche se alcune istituzioni, come l’Oms, sono state più lente a prenderne atto) e che, viceversa, finora nessuna delle teoria complottiste o bufale sulla pandemia è stata invece confermata. Al contrario, queste continuano a circolare nonostante siano state più volte confutate dai dati. È questo uno dei principali indizi su come le pseudoscienze non siano reale conoscenza scientifica: non mutano idea di fronte all’evidenza, restano ferme sulle loro posizioni nonostante ogni prova contraria. Il fatto che la scienza abbia corretto i suoi errori è proprio quanto, invece, dovrebbe garantire che possiamo fidarci. La scienza sa dire “ho sbagliato”: le teorie possono essere ribaltate quando vengono raccolti nuovi dati e fatti nuovi esperimenti. È proprio per questo che fidarci della scienza è la cosa migliore che possiamo fare, anche quando sbaglia.



- Non è vero che uno studio ha mostrato un aumento della mortalità cardiaca negli USA dopo i vaccini anti-CovidNon è vero che uno studio ha mostrato un aumento della mortalità cardiaca negli USA dopo i vaccini anti-Covid
- No, questo manichino non è stato spacciato per un paziente Covid-19No, questo manichino non è stato spacciato per un paziente Covid-19




