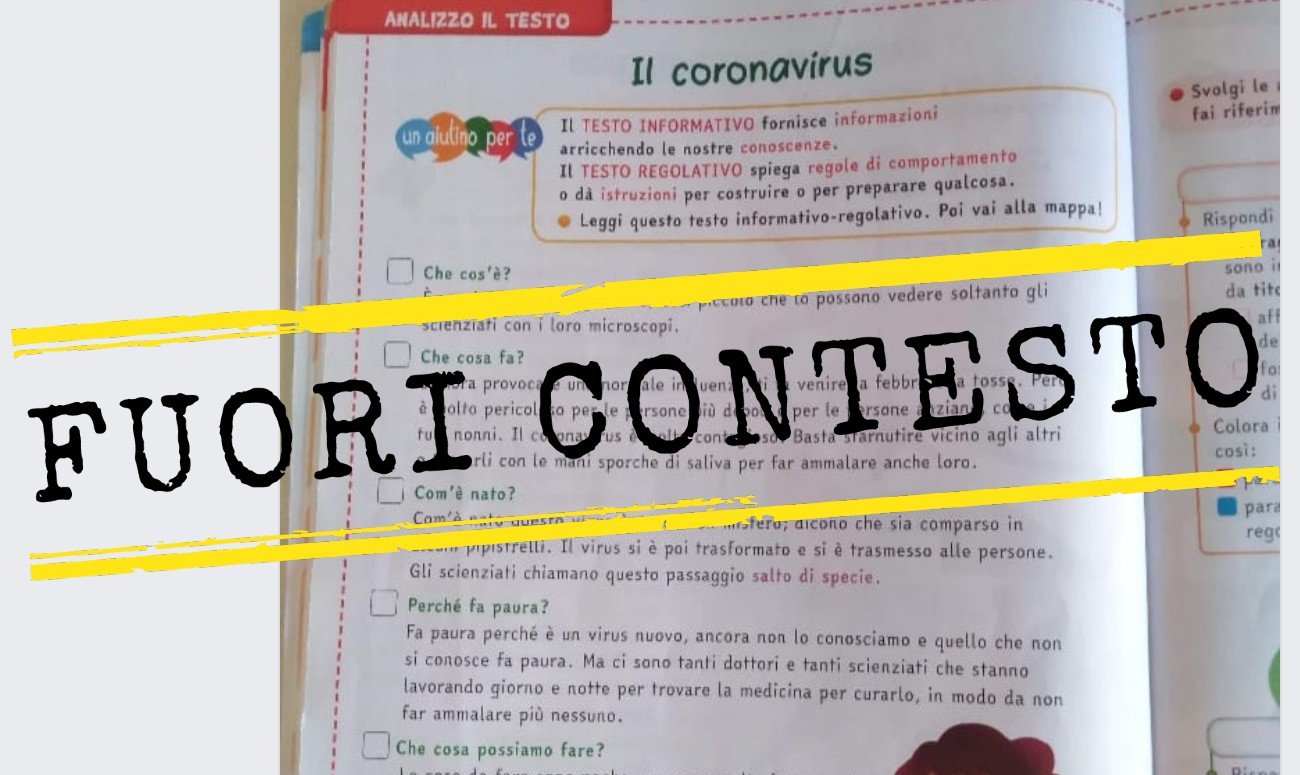
Il nuovo coronavirus era già in Italia a settembre 2019?
[…]
L’11 novembre 2020 è stato pubblicato sulla rivista accademica Tumori Journal uno studio scientifico intitolato “Unexpected detection of Sars-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy” – in italiano, “Inattesa rilevazione di anticorpi contro Sars-CoV-2 nel periodo pre-pandemia in Italia” – e firmato da sedici ricercatori italiani guidati da Gabriella Sozzi e Ugo Pastorino, rispettivamente ricercatrice e medico presso la Fondazione Irccs – Istituto Nazionale Tumori di Milano. Stando allo studio, il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 responsabile della pandemia di Covid-19 sarebbe stato già ampiamente in circolazione in Italia a settembre 2019. Tre mesi in anticipo rispetto ai primi casi di Covid-19 ufficialmente identificati a Wuhan a fine dicembre 2019.
Lo studio è rapidamente circolato sui media in Italia e anche all’estero. È corretto credere a tutte le sue conclusioni? Diversi ricercatori, come ad esempio il biologo Enrico Bucci, l’epidemiologa Stefania Salmaso e l’immunologa Antonella Viola in Italia e, all’estero, Francois Balloux dell’Istituto di Genetica dell’University College London, hanno espresso immediatamente forti perplessità. Come mai?
Come disse l’astronomo e divulgatore Carl Sagan, «affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie», ma purtroppo non sembra questo il caso.
Che cosa dice lo studio
Gli autori dello studio hanno analizzato campioni di sangue raccolti su un totale di 959 persone che tra settembre 2019 e marzo 2020 hanno partecipato a uno studio clinico sul tumore al polmone (non correlato quindi alla Covid-19). Più di metà dei campioni di sangue proviene dalla Lombardia, mentre gli altri da altre regioni italiane, principalmente dal Lazio e da località del Nord Italia. I ricercatori hanno cercato anticorpi capaci di riconoscere il coronavirus Sars-Cov-2. Si tratta di una indagine equivalente a un test sierologico, che sfrutta il comune test Elisa.
Il risultato è che 111 dei 959 pazienti testati (l’11,6 per cento circa) mostrano anticorpi capaci di riconoscere Sars-Cov-2, come se si fossero già infettati col virus. Una percentuale molto più alta rispetto ai dati epidemiologici del Ministero della Sanità, che mostravano al 27 luglio 2020 una esposizione complessiva al Sars-CoV-2 del 2,5 per cento. Sorprendente è che molti di questi campioni positivi risalgano a settembre, ottobre e novembre 2019: le percentuali di campioni di sangue positivi per questi tre mesi sono 14,2 per cento, 16,3 per cento e 9,5 per cento.
Da questi risultati gli autori hanno dedotto che in Italia una quantità molto alta di persone doveva aver contratto Sars-Cov-2 a settembre 2019, il che significherebbe che il virus doveva essere in circolazione nel Paese da quella data e, vista l’alta quantità di persone che sarebbero risultate infette, probabilmente anche un mese o due prima. Ciò sposterebbe indietro di parecchio l’origine della pandemia, all’estate 2019. La maggior parte dei campioni infetti proviene dalla Lombardia, aspetto che secondo gli autori si troverebbe in accordo con la diffusione della Covid-19 durante la prima ondata di febbraio-aprile 2020.
Lo studio è stato pubblicato su una rivista accademica minore affiliata al gruppo editoriale Sage Publishing, Tumori Journal, il cui capo di redazione e gran parte dei redattori sono affiliati alla Fondazione Irccs – Istituto Nazionale dei Tumori.
Nell’articolo si legge che questo è stato ricevuto dalla rivista e accettato per la pubblicazione lo stesso giorno, il 29 ottobre 2020. Non è chiaro come possa essere stato sottoposto a peer review in meno di 24 ore: il tempo medio per ricevere un responso di peer review è solitamente di 8-9 settimane. Con l’urgenza dovuta alla pandemia è diventato molto più rapido negli ultimi mesi ma sempre dell’ordine di 5-23 giorni. Secondo un commento di Valentina Bollati (co-autrice dello studio) postato sul gruppo chiuso di Facebook dell’associazione di ricercatori italiani Airi, «in realtà non ci sono volute 24 ore», ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.
Il controllo che non c’è
Al di là della rivista su cui è stato pubblicato e della (forse) veloce revisione fatta, le conclusioni dello studio mostrano alcune difficoltà. Il principale grande limite è che non c’è, apparentemente, nessun controllo sul fatto che gli anticorpi riconosciuti dai test siano effettivamente specifici per Sars-Cov-2 e non per altri coronavirus.
Sappiamo infatti che una percentuale piccola ma significativa di persone non infettate da Sars-Cov-2 possiedono anticorpi capaci di riconoscere il nuovo coronavirus: il 5 per cento, ad esempio, secondo uno studio pubblicato su Science il 6 novembre 2020 (su Facta ne abbiamo discusso qui). Questo è dovuto con ogni probabilità al fatto che in una minoranza di casi gli anticorpi sviluppati dall’organismo contro altri coronavirus, normalmente in circolazione e che causano comuni raffreddori, possono riconoscere anche il virus Sars-Cov-2, a cui in parte assomiglia.
È vero che il test dello studio usa, per individuare gli anticorpi, una regione della proteina virale Spike detta Rbd (Receptor Binding Domain) che dovrebbe essere molto specifica per Sars-Cov-2. Stanno però emergendo dei dati che mostrano come possano esserci anticorpi specifici per Rbd anche in campioni non infetti da Sars-Cov-2: in questo studio, pubblicato per ora come preprint, il 2 per cento di campioni di siero sanguigno raccolto nel 2017 da pazienti sani e depositato nella Penn Medicine Biobank conteneva anticorpi di tipo IgG che riconoscono la regione Rbd: una percentuale pressoché identica a quella osservata nello studio Irccs, che va dal 0,9 a 2,4 per cento.
Riassumendo: sappiamo che anche persone non infette dal virus Sars-CoV-2 possono a volte produrre anticorpi che accidentalmente riconoscono il virus Sars-CoV-2, e gli autori dello studio non sembrano aver tenuto conto esplicitamente di questa possibilità.
I ricercatori dello studio Irccs infatti non fanno poi nessun riferimento al controllo sulla specificità del loro test: né all’interno dell’articolo scientifico da loro scritto, né nei materiali supplementari ad esso allegati, né all’interno di un altro articolo che, citato in bibliografia, dovrebbe descrivere il test da loro utilizzato.
Anzi, all’interno di quest’ultimo (dal titolo «Comparative analyses of SARS-CoV-2 binding – IgG, IgM, IgA – and neutralizing antibodies from human serum samples», in italiano «Analisi comparativa di anticorpi IgG, IgM e IgA che legano e neutralizzano Sars-CoV-2») viene scritto esplicitamente che «il prossimo passo sarà di validare completamente questi ELISA […] e di analizzare la performance e specificità di questi test con campioni di siero sanguigno umano che sono altamente positivi verso altri coronavirus umani». La precisazione sembra implicare che tali test, al momento della pubblicazione, non erano stati ancora fatti. È sicuramente possibile che le cose siano cambiate, ma gli autori non offrono alcun dato al riguardo.
Il 15 novembre 2020 Gabriella Sozzi, una delle autrici dell’articolo, ha sostenuto su Twitter che tali test sono già stati fatti ma non inseriti nell’articolo. In un commento sul gruppo Facebook dell’associazione di ricercatori italiani Airi un’altra autrice dello studio, Valentina Bollati, ha confermato questa versione.
Nello studio si dichiara inoltre di aver convalidato i risultati usando un cosiddetto «test di microneutralizzazione», un test in cui si osserva se il siero dei pazienti è capace di impedire la crescita del virus Sars-Cov-2 in laboratorio. Dei 111 campioni positivi solo 6 (il 5,4 per cento) mostrano questa capacità, il che sembra in contrasto con l’idea che i campioni positivi fossero stati effettivamente infettati da Sars-Cov-2. Di nuovo, una piccola percentuale di anticorpi attivi in questi test è già stata osservata anche in campioni risalenti a prima del 2019.
Un virus un po’ troppo diffuso
Uno dei punti di forza apparenti dello studio è che la distribuzione geografica dei positivi sembra a grandi linee coerente con la diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia durante la prima ondata. In particolare la maggior parte dei campioni positivi (59 su 111, 53,2 per cento del totale) proviene dalla Lombardia, regione che più delle altre ha dovuto combattere con l’emergenza sanitaria. Gli autori scrivono che «la distribuzione geografica degli individui positivi a Sars-Cov-2 identificati nel nostro studio rispecchia da vicino l’incidenza della Covid-19 registrata ufficialmente in Italia» e «la maggior parte dei primi individui positivi agli anticorpi viveva in regioni dove è iniziata la pandemia».
In realtà basta guardare la tabella sulla composizione del campione di pazienti, pubblicata come materiale supplementare allegato allo studio (tabella S3), per accorgersi che vengono scoperti più campioni positivi in Lombardia semplicemente perché la maggior parte dei loro campioni di siero (il 53,2 per cento) viene proprio dalla Lombardia. Usando la loro tabella per calcolare la percentuale di positivi in ciascuna regione, si osserva che Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana e Liguria avrebbero avuto una percentuale di positivi al Sars-Cov-2 pari o leggermente superiore a quella della Lombardia.
Per le prime sei regioni in tabella, ovvero quelle con un numero di campioni sufficientemente alto per poter ottenere dei numeri in qualche modo significativi, lo studio trova sistematicamente circa la stessa percentuale di positivi in ogni regione: il 13 (±2,5) per cento.
Questo rende ancora più discutibili le conclusioni dello studio: implica che il Sars-Cov-2 sarebbe stato diffuso nel 10 per cento della popolazione in praticamente tutte le regioni italiane per mesi, per poi “esplodere” a febbraio e marzo solo in alcune di queste. È invece un risultato del tutto coerente con un problema sistematico nella procedura sperimentale, indipendente dall’origine del campione.
In conclusione
Stabilire se uno studio scientifico corrisponde o meno a verità è compito della comunità scientifica. Analizzando lo studio recentemente diventato virale e che retrodaterebbe la comparsa del nuovo coronavirus in Italia a settembre 2019, abbiamo però scoperto alcuni punti critici che dovrebbero indurre cautela. Bisogna aspettare ulteriori studi per confermare o meno in modo più solido i risultati recentemente ottenuti.
Al momento le conclusioni dello studio Irccs contrastano con i dati genetici sull’origine del coronavirus Sars-Cov-2 che identificano l’origine internazionale della pandemia tra ottobre e dicembre 2019. È vero che il virus era in circolo, in Italia e nel mondo, prima che ce ne accorgessimo. La prima infezione confermata in Cina sembra infatti risalire al 17 novembre 2019. I successivi primi casi confermati in Europa tramite test genetici, che come abbiamo già raccontato sono altamente specifici per il virus, risalgono a fine dicembre 2019, e un’analisi genetica delle acque reflue in Italia pubblicata dall’Iss ha riscontrato la possibilità che il virus circolasse nel nostro Paese già a dicembre 2019.
Ma i risultati dello studio Irccs sono incompatibili con i dati sanitari, visto che se il virus fosse avesse avuto una circolazione così ampia, con addirittura il 10 per cento di infetti, avrebbe dovuto causare una significativa ondata di ricoveri prima in Cina e poi in Europa all’inizio dell’autunno 2019, di cui non c’è stata traccia, a differenza della prima e seconda ondata di Covid-19 del 2020. Tutti i pazienti positivi identificati dallo studio oggetto della nostra analisi erano privi di sintomi della Covid-19, il che è sorprendente su 111 pazienti visto che – come abbiamo approfondito – gli asintomatici sono intorno al 50 per cento.
Nessuna di queste cose, di per sé, invalida lo studio, ma lo inquadra come dato contrario a numerosi altri dati indipendenti. Il che può certamente succedere, ma dovrebbe essere corroborato da una base sperimentale e di analisi assai solida perché possa essere preso in seria considerazione.
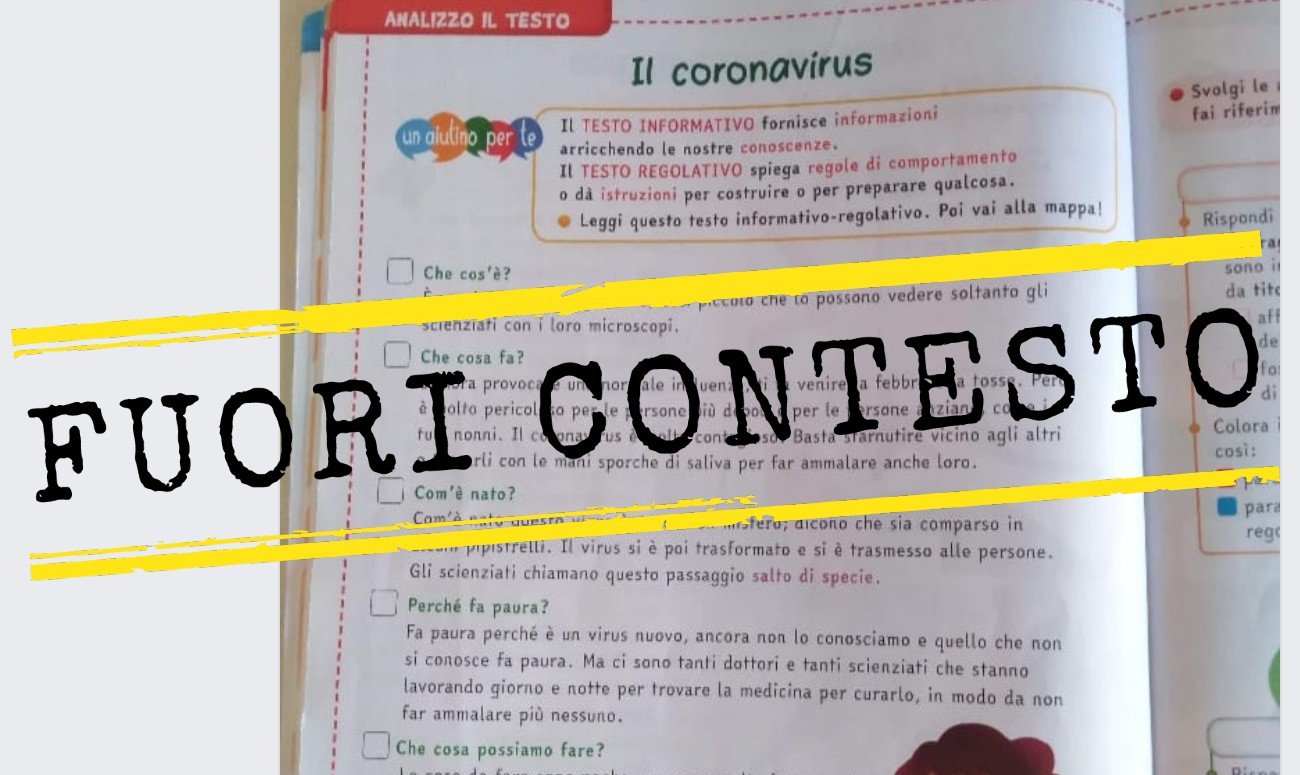
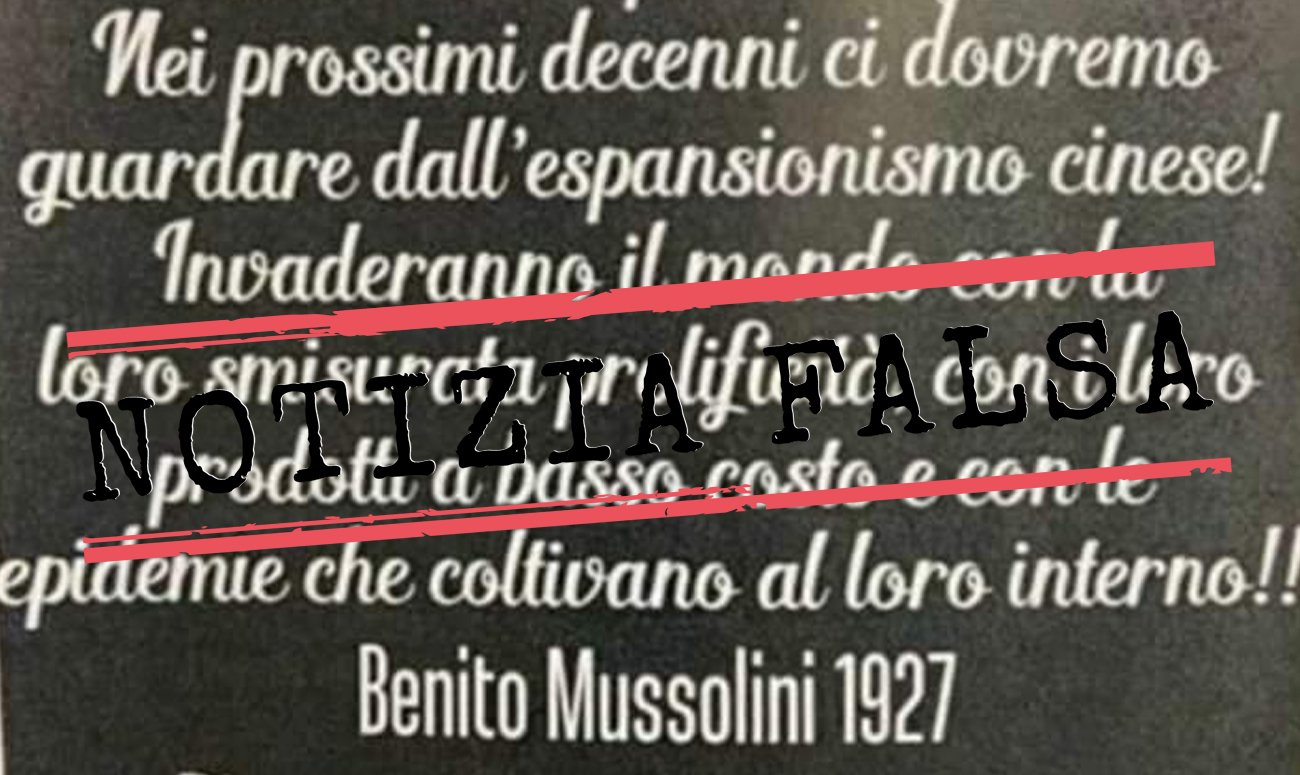

- Non è vero che il vaccino anti-Covid autoamplificante è pericoloso per l’uomoNon è vero che il vaccino anti-Covid autoamplificante è pericoloso per l’uomo
- Sono cinque anni che la fuga dal laboratorio non spiega l’origine del coronavirus
 Sono cinque anni che la fuga dal laboratorio non spiega l’origine del coronavirus
Sono cinque anni che la fuga dal laboratorio non spiega l’origine del coronavirus



